Autobiografia
di Marcoz Dega ovvero Metamorfosi
Io
sono Marcoz Dega.
Io
ero Marcoz Dega.
Ma
cominciamo dall’inizio. Il mio primo ricordo è vago e
fumoso – naturalmente – e consiste di pochi frammenti di
una partita a carte giocata da mani grosse e vecchie su un tavolo
marrone. Non c’è dubbio che fossero le mani del Nonno
(materno) che mi portava con sé nei pomeriggi molli di un ex
ferroviere, al bar Biffi, che a quei tempi aveva una certa fama, e lì
si trovavano i migliori giocatori di tresette della provincia. Già
all’asilo mi chiamavano Dega, soprannome che s’ottiene
abbreviando il mio cognome. All’epoca lo trovavo estremamente
offensivo, per via della a alla fine, che lo rendeva
vergognosamente femminile. E più protestavo, e più il
Nonno veniva in mio soccorso, distribuendo sculacciate a quelle pesti
dei miei compagni, più quel nome mi s’incollava addosso,
ed io divenivo con quel nome una cosa sola, si creava insomma
un’identità tra linguaggio e realtà, quasi
fossimo stati degli ebrei. Ma quest’identità ad un
certo punto della mia vita, si sciolse, e se ciò è
stato un bene o un male, io non so dirlo. All’asilo facevo
parte dei fiori rossi in eterna competizione coi gialli ed i
blu. Fu lì che conobbi M. T. che ovviamente militava tra le
fila del gruppo dei gialli, quello a cui appartenevano i figli della
elite, i rampolli della Cremona bene, con metri e metri di
puzza sotto al naso, ma che evitano di farsi la doccia tutti i giorni
per non spendere troppo in acqua corrente. (Devo dire, però,
che nemmeno io ho mai avuto le mani bucate, e ho sempre amministrato
la paghetta del Nonno con parsimonia ed oculatezza, e forse è
stato quando ho smesso di farlo che sono accaduti i fatti che mi
portano a scrivere questa storia, e che hanno stravolto la mia
esistenza.) Le suore dell’asilo del Sacro Cuore avevano in
comune col Cristo solo la peluria facciale, per il resto
assomigliavano di più a kapò senza pietà,
e non mi permettevano nemmeno di prolungare, fino a quando
desiderassi, il sonnellino pomeridiano: una sorta di tortura della
privazione del sonno, senza uno scopo. Tipicamente nazista. E’
forse in quel periodo che nacque in me, seppur in forma larvale ed
inespressa, l’insofferenza che tuttora provo verso la Chiesa ed
i suoi adepti. Nulla contro la religione in sé, sia chiaro,
addirittura mi reputo e definisco cristiano; in alcuni momenti della
vita ho avvertito una spinta potente verso il sacro e così mi
sono dedicato con dovizia allo studio dei culti misterici e
dionisiaci, ma sempre restando insoddisfatto, e traendo più
appagamento dalla sporadica fede nel Dio cristiano. Chi, dei miei
amici, se ancora si possono dire tali (sì!), chi dei miei
amici non ricorda di quella volta che cominciai ad andare a messa la
domenica, dopo aver visto La Passione di Cristo, il film diretto da
Mel Gibson? La mattina della quarta domenica successiva abbandonai
ogni velleità di salvezza, e mi girai dall’altra parte,
nel letto, riaddormentandomi come un bambino. No, non è la
Messa che salva l’Uomo, non è il Culto, non è la
Chiesa. La Ricerca è il nostro messia. Messia, ma anche
giudice. Secondo Socrate la speculazione filosofica avrebbe salvato
la sua anima. Secondo me la Ricerca salva o condanna. Devo capire se
sono stato condannato o salvato, è questo che cerco mentre
scrivo. Ma mi sto dilungando oltre misura; torniamo al breve racconto
della mia infanzia. Dicevo che non ho un ricordo positivo degli anni
trascorsi alla scuola materna, infatti fui ben felice di compiere sei
anni (ricordo chiaramente che mi venne regalato un pupazzo blu a
forma d’ippopotamo che ho conservato per anni, ma che ora non
trovo più) e d’iscrivermi alle elementari.
Furono
anni semplici, è il miglior aggettivo che trovo per
descriverli. La maggiore preoccupazione che avevo era la verifica di
Storia d’ogni mese, per il resto non avevo pensieri. Sognavo
spesso auto veloci e fiammanti, Ferrari in particolare, e mi
appassionavo ai campionati di calcio, anche se la mia squadra del
cuore, l’Inter, non vinceva mai lo scudetto; ma il Nonno tifava
Inter, ed io non potevo esimermi dal fare lo stesso. Ero un asso del
pallone. All’oratorio venivo considerato tra i migliori
tiratori. Peccato non abbia coltivato questa preziosa abilità,
forse oggi sarei miliardario e mi troverei seduto al Billionaire
insieme a Briatore e Materazzi, con un bicchiere di champagne in una
mano e la coscia di una velina nell’altra. Sta di fatto che ero
anche tra i primi della mia classe, come rendimento, voti ed
intelligenza, per questo lasciai perdere lo sport e mi concentrai
sullo studio. A onor del vero, devo aggiungere che sì, avevo
un buon piede, ma il fisico mingherlino ed asciutto non mi permetteva
di sostenere gli scontri con gli avversari; inoltre, allora, ero
piuttosto basso. M.T. – non vi ho detto che lo ritrovai nella
mia classe alle elementari – mi chiamava Nemecsek, come quel
personaggio dei Ragazzi della Via Pal che moriva di polmonite.
Fortunatamente questo epiteto finì presto per essere
dimenticato. Anni semplici e fugaci.
Alle
medie, trascorrevo i pomeriggi a casa di M.T., che sostanzialmente mi
schiavizzava, e mi costringeva e fare anche i suoi compiti a casa,
altrimenti mi sarei beccato decine di pallottole di plastica
dolorosissima che venivano sparate da una pistola giocattolo, oppure,
peggio ancora, avrei dovuto trascorrere, nel caso in cui fosse
inverno, ore intere chiuso sul balcone al freddo e senza giacca.
Preferivo di gran lunga fare i compiti anche per lui, e d’altronde
non posso tacere il fatto che a quei tempi provavo una sorta di
venerazione per M. T., che, data l’identità sessuale
tipicamente immatura dei tredicenni, sfociava in un tacito sentimento
quasi amoroso, che mai osai rivelare, e certo non me ne pento! Non
sono omosessuale, caro lettore, se è questo a cui stai
pensando. Niente di più sbagliato. Se fossi omosessuale, forse
non sarei dove sono ora e come sono ora, forse sarei ancora il
vecchio Dega, e tu non leggeresti queste parole di verità che
scorrono dalla mia penna. Se fossi stato omosessuale, non avrei
indossato per diversi anni una tuta sportiva, comoda sì, ma
decisamente antiestetica. Avessi continuato a farlo! Anche nel fatto
che ad un tratto cominciai a ricercare l’eleganza, a seguire la
moda, vedo i primi segni del cambiamento, della Metamorfosi.
Il
liceo. Ah, il liceo! Presi la decisione di iscrivermi al Classico, il
giorno prima della chiusura delle iscrizioni. Non so perché lo
feci. Già allora amavo la Matematica ed ero orientato verso
studi di tipo scientifico. Forse fu che avvertii l’esigenza di
allargare la mia cultura – ero assetato di sapere – ,
forse della Matematica mi piacevano di più le implicazioni
filosofiche, l’idea che fosse un linguaggio e l’esercizio
di calcolo in sé non m’affascinava. O forse, il vero
motivo fu che M. T. si iscrisse al Classico ed io semplicemente lo
seguii.
Ma
presto maturai. Cominciavo a staccarmi da lui. Gli stimoli
intellettuali a cui ero sottoposto, il fascino della novità,
la passione per il sapere occupavano i miei pensieri; m’immersi
in profondità nello studio, in particolare della lingua greca.
Acquisii con facilità, la capacità di comprensione di
quell’idioma magnifico, e ben presto riuscii a plasmare frasi
sempre più complesse in greco, divenendo uno dei pochi a cui
gli altri desideravano sedersi vicino durante i compiti in classe,
per trarre spunto dalle mie traduzioni. All’inizio del liceo,
mi trovavo di pomeriggio con G. M., un ragazzo grande e grosso
d’origine piacentina e d’indole fondamentalmente
campagnola, e N. R., che già allora veniva considerato pazzo –
il suo compagno di banco, tale M. C. arrivava a casa stravolto ogni
giorno trascorso a stretto contatto con N. R. , tanto che la madre si
lamentava con noi dello stress quotidiano a cui era esposto il
figlio. M. C. era, come me, un “secchione”, ma, al
contrario di me, non eccelleva anche nelle materie scientifiche, per
questo non l’ho mai stimato granché. In quei pomeriggi,
mi trovavo con i miei due nuovi amici, e si discuteva ore ed ore di
Filosofia, di Storia ,di Religione e di Linguistica (ora essi non lo
ricordano più, ma io sì). A volte andavamo alla
biblioteca statale (che in seguito divenne protagonista della mia
vita, ma quelli erano altri tempi) e consultavamo libri più
alti di noi – perlomeno più alti di me e N. R.. Ho qui
sottocchio la foto di classe del secondo anno di superiori:
nell’angolo in basso a destra, ci siamo io e N. R. seduti
dietro un banco, nel tentativo di mascherare la nostra impressionante
bassezza, ma non potendo nascondere il pallore diafano dei nostri
volti, forse dovuto alle pratiche autoerotiche da ragazzi di quindici
anni. Quando mi masturbavo, avevo in testa immagini vivide, quasi
reali. All’inizio pensavo ad una ragazza, la più
gettonata era una mia compagna di classe, così carina nella
sua minuta e proporzionata struttura corporea, la carnagione scura e
i capelli corvini e fluenti… (Come fui felice quella volta che
il professore assegnò, a lei ed a me, i coppia, l’analisi
della prima egloga delle Bucoliche!) Poi la mia immaginazione si
spostava su qualcosa di più indefinito e vago, come una
giornata di sole, oppure una mappa geografica - mi ricordo infatti
che eiaculavo pensando alle capitali degli Stati Uniti, quella dello
Stato di New York era la mia prediletta. Anche perché in
quello Stato c’è Newark, da cui proviene la mia
famiglia, da parte di madre, che ha origini italiane, ma che quattro
generazioni fa emigrò oltreoceano, ed un ramo di essa, il mio,
fece poi ritorno in Italia, ma al Nord, tanto che ho più
parenti a Parma che in Calabria. Quante domeniche felici ho trascorso
a casa di quei parenti parmigiani! Sono stati probabilmente quei
pranzi, degni d’essere descritti da un Petronio – senza
nulla togliere al sugo casereccio che cucina mia madre – a
farmi guadagnare in poco tempo, quei centimetri che mi separavano da
un’altezza dignitosa per un adolescente, anzi, in pochi mesi,
raggiunsi e superai le teste dei miei coetanei, fino a guardarli
dall’alto in basso. E poi a Parma abitava una mia cugina –
mi chiedo che fine abbia fatto ora – una di quelle cugine che
si vedono raramente, che non le consideri come tue parenti, e se sei
un adolescente, non ti fai scrupoli a desiderarle (non glielo mai
rivelato, d’altronde, a livello razionale, sapevo che si
trattava di un sentimento sconveniente). Come mi ero iscritto al
liceo per M. T., così poi mi sarei immatricolato a Parma per
via di quella mia cugina… ma non saltiamo troppo avanti con la
storia.
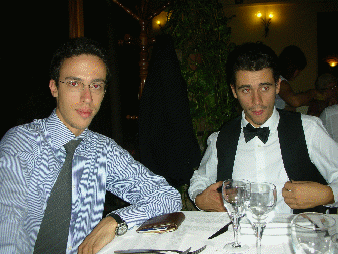 Molti
dei miei amici rimpiangono gli anni del liceo. Io no. Gli anni più
belli e felici li ho trascorsi quando frequentavo l’università.
Al liceo ero poco consapevole. Di cosa? Di tutto, probabilmente.
Quanto darei per tornare al liceo, ma con la testa che mi trovo ora.
Penserei meno allo studio, me la godrei di più. Magari, come
faccio ora, non disdegnerei solo un buon bicchiere di vino, ma anche
una sbronza esagerata, malinconica, autodistruttiva ma lenitiva al
tempo stesso. Non preoccuparti, mio unico lettore, capirai cosa
intendo. Invece, sai cosa non capirò mai? La passione morbosa
che avevano i miei compagni di classe per il corpo docenti. Sempre
pronti a invitare i professori a cena, entusiasti di essere
accompagnati in gita da questo o da quella, qualcuno aveva pure come
modello di vita un insegnante che alzava il gomito in ogni occasione
possibile, qualcun altro – e qui mi riferisco a M. T. –
sembrava innamorato del professore di Storia e Filosofia (a cui tra
l’altro io stavo particolarmente antipatico) tanto che i miei
amici lo soprannominarono, a sua insaputa – forse lo scoprirà
leggendo queste pagine - “Habibi 2”. Habibi era già
il soprannome di un altro compagno, che aveva tendenze omosessuali,
dicevamo, soprannome coniato dallo stesso M. T. di ritorno
dall’Egittto (significa “amore mio”). A me i
professori stavano un po’ tutti sulle palle,
indiscriminatamente. Ma non per loro demerito, erano brave persone,
e, per la maggior parte, bravi insegnanti; è il rapporto
intimo alunno/docente che mi indisponeva, e non tolleravo tutta
questa rincorsa maniacale al contatto extrascolastico dei miei
compagni verso i professori. Mi pento però non aver
apprezzato, come gli altri, le cene al ristorante il sabato sera,
un’usanza che è nata nel triennio, poiché prima
s’accontentavano d’una pizza insipida nella solita
pizzeria del centro. Quando studiavo all’università,
invece, ero in prima fila se si trattava di organizzare una cena
fuori, oppure nell’appartamento/studio di mio padre. Lo chiamo
“casina”, perché è un monolocale piccolo e
grazioso, arredato secondo un gusto moderno, all’insegna del
design più raffinato, che ho voluto venisse intestato a me. E’
lì che ho dipinto alcuni quadri tra quelli che considero i
miei capolavori, tra cui Maternità talebana, o La Collina dei
Samurai. Ho sempre amato i Samurai, forse per il fatto che sono un
prodotto dell’Oriente; così come, tra i miei artisti
preferiti, annovero Hokusai – in particolare i suoi disegni
erotici – e apprezzo senza misura le musiche che provengono dal
Levante, da quelle arabe, a quelle indiane dei Panjabi MC, anche se,
a onor del vero, non ho mai coltivato una vera e propria cultura
musicale, forse per pormi in antitesi con M.T. Durante gli anni del
liceo, infatti, non solo mi ero allontanato da colui il quale era
sempre stato il mio più intimo amico, ma era cresciuta in me
una sorta di insofferenza nei suoi riguardi. Mi chiedo il perché
di tale mutamento estremo. L’insofferenza, è vero,
s’accrebbe col tempo, quando, all’università, lui
si fece spocchioso e borioso, ma certamente nacque anni prima, ed
evolse in maniera graduale. Forse la metamorfosi è cominciata
allora, e quella fu una delle sue prime manifestazioni. Tu lettore,
che mi conosci, se dovessi indicare il momento esatto in cui avvenne,
nomineresti l’inizio dell’università, o quando ho
conosciuto G., ma io ti dico che successe molto prima, senza una
rottura istantanea, piuttosto con una trasformazione lenta e
graduale. L’ingegneria era per me un hobby, un passatempo. Non
dedicavo grande attenzione allo studio, da un lato perché quel
tipo di materie non è certo stimolante, dall’altro
perché la mia attenzione era, soprattutto nei primi anni,
rivolta verso l’impegno politico. Andavo ai comizi, scrivevo
per il sito del centrosinistra cremonese, ero al centro dei
riflettori quando nacque il Partito Democratico, in quanto uno dei
pochi giovani, se non il solo, che si davano da fare in prima linea.
La cosa comunque non ebbe molto seguito, e lasciai quasi stare. Avevo
perso interesse in quell’avventura politica perché ben
presto mi resi conto che ero un fantoccio dei soliti vecchi di
partito, uno slogan, che stava lì a comunicare quanto la nuova
forza politica desse spazio ai giovani e al futuro. Non era ciò
che volevo. All’epoca flirtavo anche con il mondo dell’arte
(non come pittore, ma come critico) e collaborai diversi mesi con una
rivista online che tratta di mostre ed esibizioni artistiche. Quello
fu uno dei periodi più belli ed intensi della mia vita. E fu
in quel periodo che conobbi il Lex e di conseguenza G. Non ricordo
come cominciai ad andarci. Forse per la posizione che occupa, in
centro (appena dietro al battistero di una delle più belle
cattedrali del mondo) eppure defilato (potevo fumare tutte le
sigarette che volevo, senza temere che mio padre mi scoprisse). Ben
presto divenne per me una seconda casa. Ogni sera che ero a Cremona,
non mancavo di sedermi ai tavolini fuori, preferibilmente sulle sedie
di vimini, comode e calde in ogni stagione, per l’aperitivo, ed
anche dopo cena. Con me spesso veniva G.M., il grande e grosso
piacentino. Il fine settimana andavamo in biblioteca a studiare,
leggere il giornale, fumare, chiacchierare. Verso le sei di sera
raggiungevamo velocemente il Lex. G.M. aveva (ed ha, suppongo) un
cugino di pochi anni più giovane di lui e di me, che già
conoscevo di vista, sin dai tempi dell’asilo. C’è
una foto che mia madre ritagliò dal giornale locale, che
ritrae il cugino di G.M. che s’arrampica su un “castello”
per bambini, all’asilo, e dietro, in un angolo, s’intravvede
la mia sagoma appoggiata al muro che guarda verso di lui, verso il
futuro. Per un qualche motivo, prima che lo incontrassi al Lex,
provavo verso di lui una certa avversione, non giustificabile
razionalmente. Cominciò a sedersi al tavolo con noi, tra una
birra e l’altra ci si conobbe, e ben presto, non so come,
diventammo inseparabili. Ricordo di quella volta che gli feci guidare
la mia auto - ero uscito dal Lex un po’ brillo – e
parcheggiare nel mio garage. La manovra per entrare non è per
nulla agevole. G. sterzò oltremisura finendo con l’appoggiare
l’angolo anteriore sinistro contro il muro della rampa
d’accesso. Non sapendo sbrogliare la situazione, mi costrinse a
prendere in mano il volante. Le innumerevoli birre piccole mi
portarono a sterzare dalla parte verso cui un uomo sobrio non avrebbe
mai girato. Dovetti dire addio a buona parte della fiancata sinistra.
Ma la nostra amicizia non ebbe alcun danno, anzi ne uscì
ancora più profonda. L’aspetto importante di questa
storia è che dimostra che già allora avevo preso a
bere. Il vino m’è sempre piaciuto, ma non ho mai
ecceduto. Qell’estate – forse l’ultima che
trascorsi a Cremona – cominciai ad apprezzare la birra, in
particolare quella servita al Lex, così leggera e poco
frizzante. Ma soprattutto così economica! Nonostante ciò,
iniziai a spendere la paghetta settimanale del Nonno in aperitivi e
birre dopo cena. Anche ora, che scrivo, mi scolerei, di nuovo, una
birretta di quelle, tutta d’un fiato come ho sempre fatto.
Molti
dei miei amici rimpiangono gli anni del liceo. Io no. Gli anni più
belli e felici li ho trascorsi quando frequentavo l’università.
Al liceo ero poco consapevole. Di cosa? Di tutto, probabilmente.
Quanto darei per tornare al liceo, ma con la testa che mi trovo ora.
Penserei meno allo studio, me la godrei di più. Magari, come
faccio ora, non disdegnerei solo un buon bicchiere di vino, ma anche
una sbronza esagerata, malinconica, autodistruttiva ma lenitiva al
tempo stesso. Non preoccuparti, mio unico lettore, capirai cosa
intendo. Invece, sai cosa non capirò mai? La passione morbosa
che avevano i miei compagni di classe per il corpo docenti. Sempre
pronti a invitare i professori a cena, entusiasti di essere
accompagnati in gita da questo o da quella, qualcuno aveva pure come
modello di vita un insegnante che alzava il gomito in ogni occasione
possibile, qualcun altro – e qui mi riferisco a M. T. –
sembrava innamorato del professore di Storia e Filosofia (a cui tra
l’altro io stavo particolarmente antipatico) tanto che i miei
amici lo soprannominarono, a sua insaputa – forse lo scoprirà
leggendo queste pagine - “Habibi 2”. Habibi era già
il soprannome di un altro compagno, che aveva tendenze omosessuali,
dicevamo, soprannome coniato dallo stesso M. T. di ritorno
dall’Egittto (significa “amore mio”). A me i
professori stavano un po’ tutti sulle palle,
indiscriminatamente. Ma non per loro demerito, erano brave persone,
e, per la maggior parte, bravi insegnanti; è il rapporto
intimo alunno/docente che mi indisponeva, e non tolleravo tutta
questa rincorsa maniacale al contatto extrascolastico dei miei
compagni verso i professori. Mi pento però non aver
apprezzato, come gli altri, le cene al ristorante il sabato sera,
un’usanza che è nata nel triennio, poiché prima
s’accontentavano d’una pizza insipida nella solita
pizzeria del centro. Quando studiavo all’università,
invece, ero in prima fila se si trattava di organizzare una cena
fuori, oppure nell’appartamento/studio di mio padre. Lo chiamo
“casina”, perché è un monolocale piccolo e
grazioso, arredato secondo un gusto moderno, all’insegna del
design più raffinato, che ho voluto venisse intestato a me. E’
lì che ho dipinto alcuni quadri tra quelli che considero i
miei capolavori, tra cui Maternità talebana, o La Collina dei
Samurai. Ho sempre amato i Samurai, forse per il fatto che sono un
prodotto dell’Oriente; così come, tra i miei artisti
preferiti, annovero Hokusai – in particolare i suoi disegni
erotici – e apprezzo senza misura le musiche che provengono dal
Levante, da quelle arabe, a quelle indiane dei Panjabi MC, anche se,
a onor del vero, non ho mai coltivato una vera e propria cultura
musicale, forse per pormi in antitesi con M.T. Durante gli anni del
liceo, infatti, non solo mi ero allontanato da colui il quale era
sempre stato il mio più intimo amico, ma era cresciuta in me
una sorta di insofferenza nei suoi riguardi. Mi chiedo il perché
di tale mutamento estremo. L’insofferenza, è vero,
s’accrebbe col tempo, quando, all’università, lui
si fece spocchioso e borioso, ma certamente nacque anni prima, ed
evolse in maniera graduale. Forse la metamorfosi è cominciata
allora, e quella fu una delle sue prime manifestazioni. Tu lettore,
che mi conosci, se dovessi indicare il momento esatto in cui avvenne,
nomineresti l’inizio dell’università, o quando ho
conosciuto G., ma io ti dico che successe molto prima, senza una
rottura istantanea, piuttosto con una trasformazione lenta e
graduale. L’ingegneria era per me un hobby, un passatempo. Non
dedicavo grande attenzione allo studio, da un lato perché quel
tipo di materie non è certo stimolante, dall’altro
perché la mia attenzione era, soprattutto nei primi anni,
rivolta verso l’impegno politico. Andavo ai comizi, scrivevo
per il sito del centrosinistra cremonese, ero al centro dei
riflettori quando nacque il Partito Democratico, in quanto uno dei
pochi giovani, se non il solo, che si davano da fare in prima linea.
La cosa comunque non ebbe molto seguito, e lasciai quasi stare. Avevo
perso interesse in quell’avventura politica perché ben
presto mi resi conto che ero un fantoccio dei soliti vecchi di
partito, uno slogan, che stava lì a comunicare quanto la nuova
forza politica desse spazio ai giovani e al futuro. Non era ciò
che volevo. All’epoca flirtavo anche con il mondo dell’arte
(non come pittore, ma come critico) e collaborai diversi mesi con una
rivista online che tratta di mostre ed esibizioni artistiche. Quello
fu uno dei periodi più belli ed intensi della mia vita. E fu
in quel periodo che conobbi il Lex e di conseguenza G. Non ricordo
come cominciai ad andarci. Forse per la posizione che occupa, in
centro (appena dietro al battistero di una delle più belle
cattedrali del mondo) eppure defilato (potevo fumare tutte le
sigarette che volevo, senza temere che mio padre mi scoprisse). Ben
presto divenne per me una seconda casa. Ogni sera che ero a Cremona,
non mancavo di sedermi ai tavolini fuori, preferibilmente sulle sedie
di vimini, comode e calde in ogni stagione, per l’aperitivo, ed
anche dopo cena. Con me spesso veniva G.M., il grande e grosso
piacentino. Il fine settimana andavamo in biblioteca a studiare,
leggere il giornale, fumare, chiacchierare. Verso le sei di sera
raggiungevamo velocemente il Lex. G.M. aveva (ed ha, suppongo) un
cugino di pochi anni più giovane di lui e di me, che già
conoscevo di vista, sin dai tempi dell’asilo. C’è
una foto che mia madre ritagliò dal giornale locale, che
ritrae il cugino di G.M. che s’arrampica su un “castello”
per bambini, all’asilo, e dietro, in un angolo, s’intravvede
la mia sagoma appoggiata al muro che guarda verso di lui, verso il
futuro. Per un qualche motivo, prima che lo incontrassi al Lex,
provavo verso di lui una certa avversione, non giustificabile
razionalmente. Cominciò a sedersi al tavolo con noi, tra una
birra e l’altra ci si conobbe, e ben presto, non so come,
diventammo inseparabili. Ricordo di quella volta che gli feci guidare
la mia auto - ero uscito dal Lex un po’ brillo – e
parcheggiare nel mio garage. La manovra per entrare non è per
nulla agevole. G. sterzò oltremisura finendo con l’appoggiare
l’angolo anteriore sinistro contro il muro della rampa
d’accesso. Non sapendo sbrogliare la situazione, mi costrinse a
prendere in mano il volante. Le innumerevoli birre piccole mi
portarono a sterzare dalla parte verso cui un uomo sobrio non avrebbe
mai girato. Dovetti dire addio a buona parte della fiancata sinistra.
Ma la nostra amicizia non ebbe alcun danno, anzi ne uscì
ancora più profonda. L’aspetto importante di questa
storia è che dimostra che già allora avevo preso a
bere. Il vino m’è sempre piaciuto, ma non ho mai
ecceduto. Qell’estate – forse l’ultima che
trascorsi a Cremona – cominciai ad apprezzare la birra, in
particolare quella servita al Lex, così leggera e poco
frizzante. Ma soprattutto così economica! Nonostante ciò,
iniziai a spendere la paghetta settimanale del Nonno in aperitivi e
birre dopo cena. Anche ora, che scrivo, mi scolerei, di nuovo, una
birretta di quelle, tutta d’un fiato come ho sempre fatto.
Ed
era una sera ebbra, quella in cui La vidi.
Sedevo
al tavolo nella gabbia, con le spalle rivolte al muro e G. di fronte
a me; tra di noi, due chiare schiumose e fresche. Guardai G. e gli
domandai chi fosse quella ragazza dietro di lui. Si voltò
lentamente, ispezionando la sala. Non appena la vide, capì
subito di chi stavo parlando. Il caso voleva che si trattasse proprio
di una sua amica di vecchia data. La chiamò al nostro tavolo e
la fece sedere su uno sgabello. La voce mi tremava mentre mi
presentavo. Subito dopo caddi in un mutismo assoluto, e Lei continuò
per una decina di minuti a conversare con G. senza degnarmi di uno
sguardo. Ma io continuavo a fissarla, e già sentivo crescere
in me una passione forte, romantica ed animalesca nello stesso tempo.
Mi ero sempre considerato una monade, un atomo stabile, un essere
completo in se stesso. Quella sera m’accorsi che senza di Lei
non ero affatto compiuto. Capii, e non avevo alcun dubbio, che in Lei
avrei trovato il vero me stesso, la mia forma compiuta, l’eternità
che è propria della perfezione!
Quella
fu l’unica volta che La incontrai. Ora, da sotto questo ponte,
guardo le terrazze romane su cui mi troverei se non avessi perso la
strada, se la Metamorfosi non fosse mai avvenuta.
Comunque
rimane uno sfigato. sg
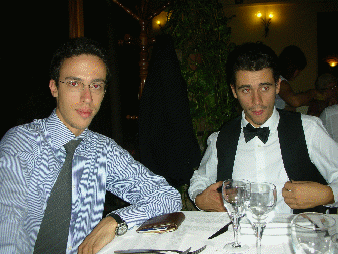 Molti
dei miei amici rimpiangono gli anni del liceo. Io no. Gli anni più
belli e felici li ho trascorsi quando frequentavo l’università.
Al liceo ero poco consapevole. Di cosa? Di tutto, probabilmente.
Quanto darei per tornare al liceo, ma con la testa che mi trovo ora.
Penserei meno allo studio, me la godrei di più. Magari, come
faccio ora, non disdegnerei solo un buon bicchiere di vino, ma anche
una sbronza esagerata, malinconica, autodistruttiva ma lenitiva al
tempo stesso. Non preoccuparti, mio unico lettore, capirai cosa
intendo. Invece, sai cosa non capirò mai? La passione morbosa
che avevano i miei compagni di classe per il corpo docenti. Sempre
pronti a invitare i professori a cena, entusiasti di essere
accompagnati in gita da questo o da quella, qualcuno aveva pure come
modello di vita un insegnante che alzava il gomito in ogni occasione
possibile, qualcun altro – e qui mi riferisco a M. T. –
sembrava innamorato del professore di Storia e Filosofia (a cui tra
l’altro io stavo particolarmente antipatico) tanto che i miei
amici lo soprannominarono, a sua insaputa – forse lo scoprirà
leggendo queste pagine - “Habibi 2”. Habibi era già
il soprannome di un altro compagno, che aveva tendenze omosessuali,
dicevamo, soprannome coniato dallo stesso M. T. di ritorno
dall’Egittto (significa “amore mio”). A me i
professori stavano un po’ tutti sulle palle,
indiscriminatamente. Ma non per loro demerito, erano brave persone,
e, per la maggior parte, bravi insegnanti; è il rapporto
intimo alunno/docente che mi indisponeva, e non tolleravo tutta
questa rincorsa maniacale al contatto extrascolastico dei miei
compagni verso i professori. Mi pento però non aver
apprezzato, come gli altri, le cene al ristorante il sabato sera,
un’usanza che è nata nel triennio, poiché prima
s’accontentavano d’una pizza insipida nella solita
pizzeria del centro. Quando studiavo all’università,
invece, ero in prima fila se si trattava di organizzare una cena
fuori, oppure nell’appartamento/studio di mio padre. Lo chiamo
“casina”, perché è un monolocale piccolo e
grazioso, arredato secondo un gusto moderno, all’insegna del
design più raffinato, che ho voluto venisse intestato a me. E’
lì che ho dipinto alcuni quadri tra quelli che considero i
miei capolavori, tra cui Maternità talebana, o La Collina dei
Samurai. Ho sempre amato i Samurai, forse per il fatto che sono un
prodotto dell’Oriente; così come, tra i miei artisti
preferiti, annovero Hokusai – in particolare i suoi disegni
erotici – e apprezzo senza misura le musiche che provengono dal
Levante, da quelle arabe, a quelle indiane dei Panjabi MC, anche se,
a onor del vero, non ho mai coltivato una vera e propria cultura
musicale, forse per pormi in antitesi con M.T. Durante gli anni del
liceo, infatti, non solo mi ero allontanato da colui il quale era
sempre stato il mio più intimo amico, ma era cresciuta in me
una sorta di insofferenza nei suoi riguardi. Mi chiedo il perché
di tale mutamento estremo. L’insofferenza, è vero,
s’accrebbe col tempo, quando, all’università, lui
si fece spocchioso e borioso, ma certamente nacque anni prima, ed
evolse in maniera graduale. Forse la metamorfosi è cominciata
allora, e quella fu una delle sue prime manifestazioni. Tu lettore,
che mi conosci, se dovessi indicare il momento esatto in cui avvenne,
nomineresti l’inizio dell’università, o quando ho
conosciuto G., ma io ti dico che successe molto prima, senza una
rottura istantanea, piuttosto con una trasformazione lenta e
graduale. L’ingegneria era per me un hobby, un passatempo. Non
dedicavo grande attenzione allo studio, da un lato perché quel
tipo di materie non è certo stimolante, dall’altro
perché la mia attenzione era, soprattutto nei primi anni,
rivolta verso l’impegno politico. Andavo ai comizi, scrivevo
per il sito del centrosinistra cremonese, ero al centro dei
riflettori quando nacque il Partito Democratico, in quanto uno dei
pochi giovani, se non il solo, che si davano da fare in prima linea.
La cosa comunque non ebbe molto seguito, e lasciai quasi stare. Avevo
perso interesse in quell’avventura politica perché ben
presto mi resi conto che ero un fantoccio dei soliti vecchi di
partito, uno slogan, che stava lì a comunicare quanto la nuova
forza politica desse spazio ai giovani e al futuro. Non era ciò
che volevo. All’epoca flirtavo anche con il mondo dell’arte
(non come pittore, ma come critico) e collaborai diversi mesi con una
rivista online che tratta di mostre ed esibizioni artistiche. Quello
fu uno dei periodi più belli ed intensi della mia vita. E fu
in quel periodo che conobbi il Lex e di conseguenza G. Non ricordo
come cominciai ad andarci. Forse per la posizione che occupa, in
centro (appena dietro al battistero di una delle più belle
cattedrali del mondo) eppure defilato (potevo fumare tutte le
sigarette che volevo, senza temere che mio padre mi scoprisse). Ben
presto divenne per me una seconda casa. Ogni sera che ero a Cremona,
non mancavo di sedermi ai tavolini fuori, preferibilmente sulle sedie
di vimini, comode e calde in ogni stagione, per l’aperitivo, ed
anche dopo cena. Con me spesso veniva G.M., il grande e grosso
piacentino. Il fine settimana andavamo in biblioteca a studiare,
leggere il giornale, fumare, chiacchierare. Verso le sei di sera
raggiungevamo velocemente il Lex. G.M. aveva (ed ha, suppongo) un
cugino di pochi anni più giovane di lui e di me, che già
conoscevo di vista, sin dai tempi dell’asilo. C’è
una foto che mia madre ritagliò dal giornale locale, che
ritrae il cugino di G.M. che s’arrampica su un “castello”
per bambini, all’asilo, e dietro, in un angolo, s’intravvede
la mia sagoma appoggiata al muro che guarda verso di lui, verso il
futuro. Per un qualche motivo, prima che lo incontrassi al Lex,
provavo verso di lui una certa avversione, non giustificabile
razionalmente. Cominciò a sedersi al tavolo con noi, tra una
birra e l’altra ci si conobbe, e ben presto, non so come,
diventammo inseparabili. Ricordo di quella volta che gli feci guidare
la mia auto - ero uscito dal Lex un po’ brillo – e
parcheggiare nel mio garage. La manovra per entrare non è per
nulla agevole. G. sterzò oltremisura finendo con l’appoggiare
l’angolo anteriore sinistro contro il muro della rampa
d’accesso. Non sapendo sbrogliare la situazione, mi costrinse a
prendere in mano il volante. Le innumerevoli birre piccole mi
portarono a sterzare dalla parte verso cui un uomo sobrio non avrebbe
mai girato. Dovetti dire addio a buona parte della fiancata sinistra.
Ma la nostra amicizia non ebbe alcun danno, anzi ne uscì
ancora più profonda. L’aspetto importante di questa
storia è che dimostra che già allora avevo preso a
bere. Il vino m’è sempre piaciuto, ma non ho mai
ecceduto. Qell’estate – forse l’ultima che
trascorsi a Cremona – cominciai ad apprezzare la birra, in
particolare quella servita al Lex, così leggera e poco
frizzante. Ma soprattutto così economica! Nonostante ciò,
iniziai a spendere la paghetta settimanale del Nonno in aperitivi e
birre dopo cena. Anche ora, che scrivo, mi scolerei, di nuovo, una
birretta di quelle, tutta d’un fiato come ho sempre fatto.
Molti
dei miei amici rimpiangono gli anni del liceo. Io no. Gli anni più
belli e felici li ho trascorsi quando frequentavo l’università.
Al liceo ero poco consapevole. Di cosa? Di tutto, probabilmente.
Quanto darei per tornare al liceo, ma con la testa che mi trovo ora.
Penserei meno allo studio, me la godrei di più. Magari, come
faccio ora, non disdegnerei solo un buon bicchiere di vino, ma anche
una sbronza esagerata, malinconica, autodistruttiva ma lenitiva al
tempo stesso. Non preoccuparti, mio unico lettore, capirai cosa
intendo. Invece, sai cosa non capirò mai? La passione morbosa
che avevano i miei compagni di classe per il corpo docenti. Sempre
pronti a invitare i professori a cena, entusiasti di essere
accompagnati in gita da questo o da quella, qualcuno aveva pure come
modello di vita un insegnante che alzava il gomito in ogni occasione
possibile, qualcun altro – e qui mi riferisco a M. T. –
sembrava innamorato del professore di Storia e Filosofia (a cui tra
l’altro io stavo particolarmente antipatico) tanto che i miei
amici lo soprannominarono, a sua insaputa – forse lo scoprirà
leggendo queste pagine - “Habibi 2”. Habibi era già
il soprannome di un altro compagno, che aveva tendenze omosessuali,
dicevamo, soprannome coniato dallo stesso M. T. di ritorno
dall’Egittto (significa “amore mio”). A me i
professori stavano un po’ tutti sulle palle,
indiscriminatamente. Ma non per loro demerito, erano brave persone,
e, per la maggior parte, bravi insegnanti; è il rapporto
intimo alunno/docente che mi indisponeva, e non tolleravo tutta
questa rincorsa maniacale al contatto extrascolastico dei miei
compagni verso i professori. Mi pento però non aver
apprezzato, come gli altri, le cene al ristorante il sabato sera,
un’usanza che è nata nel triennio, poiché prima
s’accontentavano d’una pizza insipida nella solita
pizzeria del centro. Quando studiavo all’università,
invece, ero in prima fila se si trattava di organizzare una cena
fuori, oppure nell’appartamento/studio di mio padre. Lo chiamo
“casina”, perché è un monolocale piccolo e
grazioso, arredato secondo un gusto moderno, all’insegna del
design più raffinato, che ho voluto venisse intestato a me. E’
lì che ho dipinto alcuni quadri tra quelli che considero i
miei capolavori, tra cui Maternità talebana, o La Collina dei
Samurai. Ho sempre amato i Samurai, forse per il fatto che sono un
prodotto dell’Oriente; così come, tra i miei artisti
preferiti, annovero Hokusai – in particolare i suoi disegni
erotici – e apprezzo senza misura le musiche che provengono dal
Levante, da quelle arabe, a quelle indiane dei Panjabi MC, anche se,
a onor del vero, non ho mai coltivato una vera e propria cultura
musicale, forse per pormi in antitesi con M.T. Durante gli anni del
liceo, infatti, non solo mi ero allontanato da colui il quale era
sempre stato il mio più intimo amico, ma era cresciuta in me
una sorta di insofferenza nei suoi riguardi. Mi chiedo il perché
di tale mutamento estremo. L’insofferenza, è vero,
s’accrebbe col tempo, quando, all’università, lui
si fece spocchioso e borioso, ma certamente nacque anni prima, ed
evolse in maniera graduale. Forse la metamorfosi è cominciata
allora, e quella fu una delle sue prime manifestazioni. Tu lettore,
che mi conosci, se dovessi indicare il momento esatto in cui avvenne,
nomineresti l’inizio dell’università, o quando ho
conosciuto G., ma io ti dico che successe molto prima, senza una
rottura istantanea, piuttosto con una trasformazione lenta e
graduale. L’ingegneria era per me un hobby, un passatempo. Non
dedicavo grande attenzione allo studio, da un lato perché quel
tipo di materie non è certo stimolante, dall’altro
perché la mia attenzione era, soprattutto nei primi anni,
rivolta verso l’impegno politico. Andavo ai comizi, scrivevo
per il sito del centrosinistra cremonese, ero al centro dei
riflettori quando nacque il Partito Democratico, in quanto uno dei
pochi giovani, se non il solo, che si davano da fare in prima linea.
La cosa comunque non ebbe molto seguito, e lasciai quasi stare. Avevo
perso interesse in quell’avventura politica perché ben
presto mi resi conto che ero un fantoccio dei soliti vecchi di
partito, uno slogan, che stava lì a comunicare quanto la nuova
forza politica desse spazio ai giovani e al futuro. Non era ciò
che volevo. All’epoca flirtavo anche con il mondo dell’arte
(non come pittore, ma come critico) e collaborai diversi mesi con una
rivista online che tratta di mostre ed esibizioni artistiche. Quello
fu uno dei periodi più belli ed intensi della mia vita. E fu
in quel periodo che conobbi il Lex e di conseguenza G. Non ricordo
come cominciai ad andarci. Forse per la posizione che occupa, in
centro (appena dietro al battistero di una delle più belle
cattedrali del mondo) eppure defilato (potevo fumare tutte le
sigarette che volevo, senza temere che mio padre mi scoprisse). Ben
presto divenne per me una seconda casa. Ogni sera che ero a Cremona,
non mancavo di sedermi ai tavolini fuori, preferibilmente sulle sedie
di vimini, comode e calde in ogni stagione, per l’aperitivo, ed
anche dopo cena. Con me spesso veniva G.M., il grande e grosso
piacentino. Il fine settimana andavamo in biblioteca a studiare,
leggere il giornale, fumare, chiacchierare. Verso le sei di sera
raggiungevamo velocemente il Lex. G.M. aveva (ed ha, suppongo) un
cugino di pochi anni più giovane di lui e di me, che già
conoscevo di vista, sin dai tempi dell’asilo. C’è
una foto che mia madre ritagliò dal giornale locale, che
ritrae il cugino di G.M. che s’arrampica su un “castello”
per bambini, all’asilo, e dietro, in un angolo, s’intravvede
la mia sagoma appoggiata al muro che guarda verso di lui, verso il
futuro. Per un qualche motivo, prima che lo incontrassi al Lex,
provavo verso di lui una certa avversione, non giustificabile
razionalmente. Cominciò a sedersi al tavolo con noi, tra una
birra e l’altra ci si conobbe, e ben presto, non so come,
diventammo inseparabili. Ricordo di quella volta che gli feci guidare
la mia auto - ero uscito dal Lex un po’ brillo – e
parcheggiare nel mio garage. La manovra per entrare non è per
nulla agevole. G. sterzò oltremisura finendo con l’appoggiare
l’angolo anteriore sinistro contro il muro della rampa
d’accesso. Non sapendo sbrogliare la situazione, mi costrinse a
prendere in mano il volante. Le innumerevoli birre piccole mi
portarono a sterzare dalla parte verso cui un uomo sobrio non avrebbe
mai girato. Dovetti dire addio a buona parte della fiancata sinistra.
Ma la nostra amicizia non ebbe alcun danno, anzi ne uscì
ancora più profonda. L’aspetto importante di questa
storia è che dimostra che già allora avevo preso a
bere. Il vino m’è sempre piaciuto, ma non ho mai
ecceduto. Qell’estate – forse l’ultima che
trascorsi a Cremona – cominciai ad apprezzare la birra, in
particolare quella servita al Lex, così leggera e poco
frizzante. Ma soprattutto così economica! Nonostante ciò,
iniziai a spendere la paghetta settimanale del Nonno in aperitivi e
birre dopo cena. Anche ora, che scrivo, mi scolerei, di nuovo, una
birretta di quelle, tutta d’un fiato come ho sempre fatto.